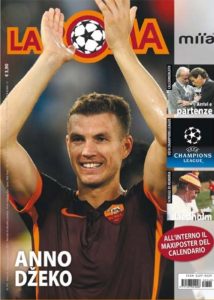ACCADDE OGGI. 17 anni fa l’ultimo saluto al Barone…
Sembra ieri, ma in realtà sono già 17 anni che il Barone Nils Liedholm è venuto a mancare. E’ venuto a mancare ai suoi cari, alla sua famiglia, al figlio che di recente abbiamo visto al Premio a lui intitolato, ma soprattutto manca a tutti noi tifosi che abbiamo avuto la fortuna chi di vederlo e chi di viverlo. Descriverlo forse non basterebbe un libro, cosi come anche raccontare tutti gli aneddoti che lo legano ai nostri ricordi. Forse più facile è dir quello che ha fatto: lui ha regalato un sogno, lui ha preso con Viola una squadra e l’ha resa grande, l’ha resa unica. Già solo per questo, non finiremo mai di ringraziarlo.
Per raccontarlo, anzi celebrarlo, usiamo le parole di Paolo Marcacci sul profilo fatto sulla nostra Rivista (342 – Settembre 2015) con la speranza di regalare un sorriso a chi lo ha vissuto, ma soprattutto far capire ai ragazzi che non lo hanno conosciuto chi fosse questo immenso uomo venuto dal Nord… Buona lettura…
NILS LIEDHOLM
(La ROMA 342 – Settembre 2015) di Paolo MARCACCI
È una storia che comincia nel ghiaccio, dove la primavera è soltanto una sfumatura meno severa dell’inverno; però matura al sole, a volte pallido, altre accecante, come i chicchi d’uva quando sono pronti per dare il vino buono, quello di cui andare orgogliosi. Ci vuole pazienza, coccolando ogni acino così come va coccolato il pallone durante una sequenza infinita di passaggi. C’è stato chi ha saputo tramandare entrambi gli insegnamenti, anche perché amava raccontare, senza mai scendere a patti con l’accento. Generazioni di cronisti, diligentemente, hanno annotato migliaia di aneddoti, in cui spesso la leggenda si è sovrapposta alla realtà ma che, proprio per questo, sono divenuti eterni, uscendo dalla cronaca per arrivare a sfiorare la letteratura. In effetti, starebbe bene in un racconto di Osvaldo Soriano, o di Eduardo Galeano, l’episodio in cui lo stadio di casa si alza in piedi per applaudire fragorosamente il centrocampista che dopo tre anni ha sbagliato un passaggio. Invece accadde a San Siro e anche se non fosse andata esattamente così, è troppo bello per metterlo in discussione.
A Waldemarsvik, il fiordo del vichingo, negli inverni prima della seconda guerra mondiale le temperature è normale che scendano a venti sotto zero; il ragazzino è piuttosto gracile, ma capisce subito che il suo miglior alleato per irrobustire il fisico può essere lo sport. Anzi, gli sport: tira di boxe, corre su varie distanze, gioca un tipo di Hockey locale particolarmente ruvido, che lo fa rientrare in casa pesto e sanguinante; addirittura fratturato, in un’occasione: alla tibia, ma si fa praticare una fasciatura strettissima affinché suo padre non se ne accorga. Vero o no che sia, è un’altra meravigliosa perla dell’aneddotica sterminata che fa da punteggiatura al racconto della vita – o delle vite? – di Nils Liedholm, a cui uno zingaro un giorno lesse la mano e gli predisse che avrebbe girato il mondo.
Il primo contatto con l’arte della divinazione, altro gustosissimo capitolo utile a spiegare le mille sfaccetture del personaggio. Il giovanissimo Nils non poteva neanche lontanamente immaginare quanto azzeccata si sarebbe rivelata la previsione dello zingaro, in barba alla sua infantile aspirazione a diventare uno dei tanti agricoltori benestanti di quel piccolo centro di case colorate e anche a dispetto di suo padre, che sognava di avere in famiglia un ragioniere.
Nel frattempo il fisico si è fatto robusto e il calcio irrompe nella sua vita con la forza inesorabile che c’è in ogni predestinazione: il giovane Nils è diventato un fior d’atleta ma, soprattutto, è nato giocatore. Possiede forza, eleganza, una naturale visione e supervisione del gioco, un tiro potente che, lo testimonieranno i numeri di tutta una carriera, fa spesso centro. Il movimento calcistico nel suo paese è ancora quasi del tutto votato al dilettantismo, nei primi anni quaranta; le cose inizieranno a cambiare quando la Svezia si aggiudicherà l’oro olimpico nel 1948. Il leader di quella selezione è Nils Liedholm, già adocchiato dal calcio professionistico italiano: le prime lusinghe arrivano dalla Juventus, la firma gliela strappa però il Milan, che lo acquista nell’estate del 1949.
Prima di volare a Milano, promette solennemente a suo padre di fermarsi in Italia per uno, massimo due anni per poi far ritorno nel paese scandinavo. È una delle battute più riuscite, col senno di poi: svestirà la maglia rossonera soltanto al termine della stagione ’60 – ’61, dopo un uno a uno casalingo contro il Lecco. Una parabola irripetibile – almeno fino al Milan di Sacchi e degli olandesi – che conta quattro scudetti e una finale di Coppa dei Campioni persa per tre a due contro il Real Madrid, durante la quale Joselito gli rifila un calcio terrificante, del quale porterà i segni a vita. Per quasi tutta la durata della sua carriera italiana, gli sono accanto i connazionali Gren e Nordhal, con i quali compone il celeberrimo Gre – No – Li: semplificazione di stampa e trio dall’impareggiabile pregio tecnico.
Diventato milanista tra le macerie della guerra, smette di esserlo – solo come giocatore – quando è già iniziato il boom economico.
Della Svezia gli restano una incancellabile cadenza fatta di joco, jocatori, Janni Rivera e numerose estati trascorse con gli amici d’infanzia ad allenarsi a segnare da calcio d’angolo. Oltre a un titolo mondiale sfiorato, nell’edizione casalinga della Coppa Rimet del 1958: da una parte Liedholm, capitano di una selezione di veterani ultratrentenni, dall’altra un ragazzino di nome Edson Arantes do Nascimento.
Se prestigiosissima è stata la carriera da calciatore, inimitabile è la sua parabola da allenatore: Milan e Roma a più riprese, con lo scudetto della stella vinto a Milano nel 1979 e l’indimenticabile tricolore riportato a Roma nel 1983, dopo quarantuno anni di attesa. In mezzo Verona, Monza, Varese, Fiorentina; eroiche salvezze, promozioni in Serie A, la scoperta di giocatori che avrebbero fatto la storia del calcio italiano: tiene a battesimo Bettega e Antognoni, investe su uno sconosciuto Carlo Ancelotti, fa decollare definitivamente la carriera di Bruno Conti. Ma, soprattutto, segna il calcio italiano col suo carisma indiscusso, con uno stile e una signorilità che già spiccavano nel calcio degli anni settanta e ottanta, senza il bisogno di operare paragoni con l’epoca attuale. Il personaggio è inimitabile anche perché in lui convivono una – apparente – imperturbabilità scandinava e una serie di ritualità superstiziose di marca mediterranea: le tasche del suo cappotto, quando va in panchina, sono sempre piene di zampe di gallina e altri amuleti. All’occorrenza, quando lo staff medico non riesce a rimettere in piedi un giocatore che gli è indispensabile, lo affida alle “cure” del mago guaritore Maggi, di Busto Arsizio. Gli affida, tra gli altri, Paulo Roberto Falcao.
A corredo di questi particolari già epici, la straordinaria ironia con cui commenta, sdrammatizza, gestisce ogni situazione. Come quando chiese a un suo giocatore se si sentisse davvero bene dal punto di vista muscolare, perché avrebbe dovuto salire le scale della tribuna.
Anche da allenatore, lo tentano le sirene juventine; anche in questo caso declina l’offerta: “Avrei vinto troppo”. È solo apparentemente una battuta. Per altre vie, Torino e il Piemonte erano comunque già entrate nella sua vita, segnandola e indirizzandone per sempre il corso, grazie al matrimonio con la Contessa Maria Lucia Gabotto di Sangiovanni, assieme alla quale acquista la tenuta “Villa Boemia”, a Cuccaro, dove risiederà fino alla fine dei suoi giorni. A Cuccaro scopre anche la passione per la viticultura: arrivato astemio in Italia, comincia per gioco a produrre vino. Diverrà un’industria vera e propria, che i figli porteranno avanti.
Se Milano è stata una moglie, Roma è stata un’amante per Nils Liedholm, lasciata a più riprese e sempre ritrovata, vissuta fino in fondo e forse ancora più fedele, nell’affetto, rispetto alla città dei navigli. La prima volta fu a metà degli anni settanta, ancora Rometta a cui era proibito qualsiasi sogno di gloria; la seconda fu vera gloria, passateci la ripetizione vagamente manzoniana: gli anni ottanta, Dino Viola, la regia tattica di Falcao che era la sua proiezione in campo, le ambizioni che diventano legittime, lo scudetto che scende sotto la Linea Gotica, l’aplomb fuori dallo spogliatoio, il pugno duro dentro, all’occorrenza. Poi i rigori al cielo di Conti e Graziani e un altro arrivederci, ancora alla volta di Milano. È tornato ancora, altre due volte, di cui una per sostituire Carlos Bianchi, che accostato al suo nome genera un ossimoro istantaneo.
Si è addormentato un giorno d’autunno del 2007, scegliendo la stagione della vendemmia. Idealmente leviamo il calice all’immenso uomo di calcio che è stato, al signore dallo stile impeccabile e dall’ironia inimitabile, alla ragnatela infinita di passaggi e ricordi, a quel volto imperturbabile ma che, come il pescatore di Fabrizio De André, aveva un solco lungo il viso, come una specie di sorriso.